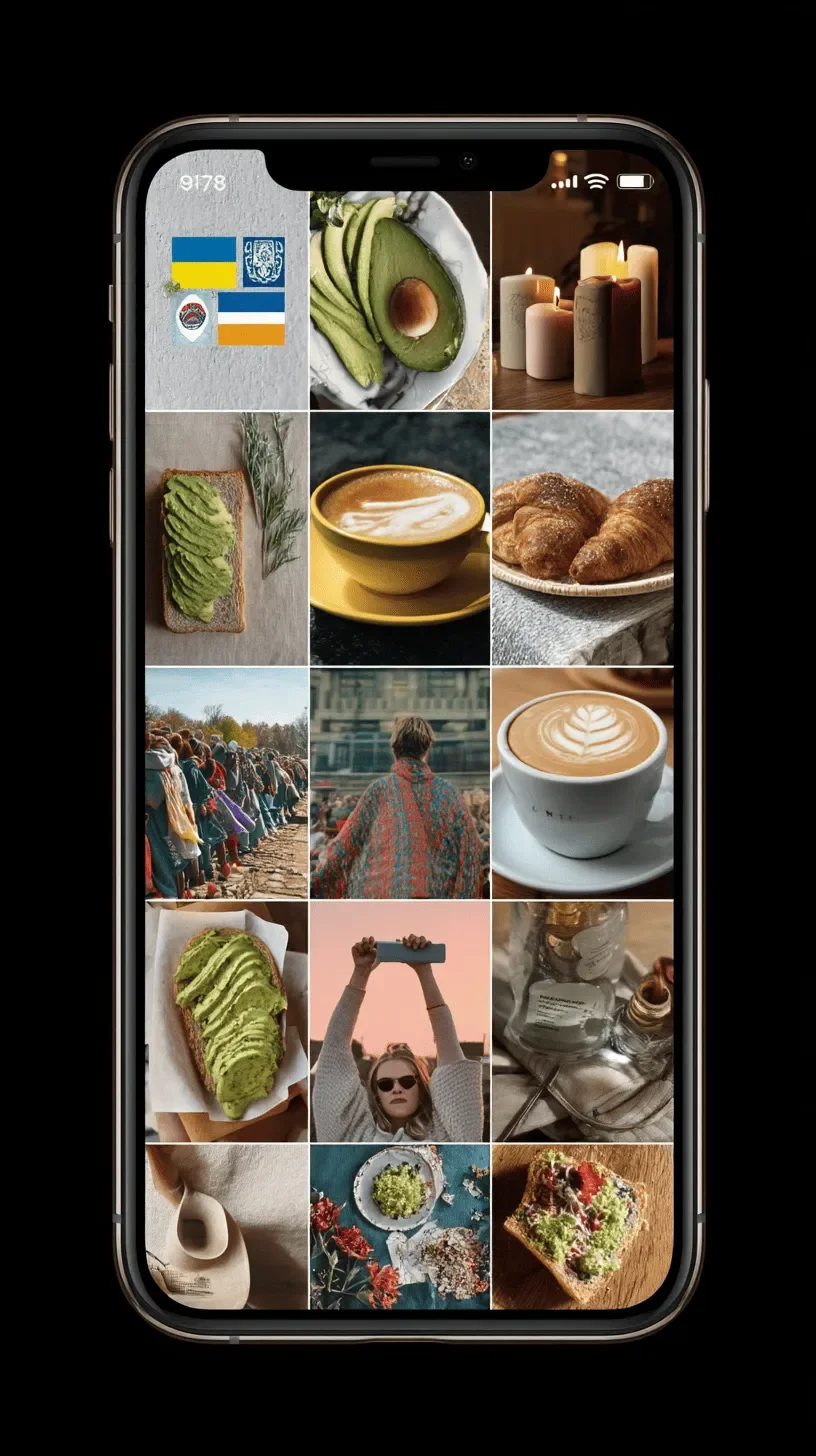Attivismo da vetrina: l'indignazione social usa e getta
La coscienza si spegne con un tap, come le luci di uno schermo.
Ho fatto il conto, venticinque cause in sei mesi. Tutte presentate come urgenti, tutte dimenticate in pochi giorni. È il Black Friday dell'indignazione, prendi tre tragedie, paghi zero.
Ho capito che qualcosa non funzionava scrollando IG. Una ragazza che conosco postava bandiere e infografiche sulla Palestina. Due giorni dopo, aperitivo in centro. Una settimana dopo, silenzio. Nessuna donazione, nessuna protesta, nessuna azione reale. Solo una story ben coordinata con il feed.
Non è cinismo, è osservazione: abbiamo trasformato l'attivismo in performance. Condividiamo, ci indigniamo, poi passiamo oltre. Confondiamo la visibilità con l'impatto, e questa confusione sta soffocando proprio le cause che diciamo di sostenere.
Il ciclo mordi e fuggi
Giorno 1: esplode una crisi. Nel giro di poche ore, il feed si riempie di infografiche che semplificano conflitti geopolitici in dieci slide. Tutti diventano esperti.
Giorno 3: arrivano le story moraliste. "Educatevi", "il silenzio è complicità". Tradotto, ho copiato un carosello da un account con font carini e ora mi sento Mandela.
Giorno 7: picco. Tutti postano, chi non lo fa viene giudicato.
Giorno 10: brunch, latte art. La causa scivola fuori dall'algoritmo.
Giorno 14: silenzio totale. Una nuova emergenza prende il posto della precedente.
Ho iniziato a tenere traccia. Non per giudicare, ma per capire: un esperimento personale su quanto a lungo resista l'indignazione della mia bolla social prima di evaporare. La risposta media è stata nove giorni. Nove giorni prima che la stessa persona che si strappava le vesti per una causa tornasse a postare foto del weekend come se nulla fosse accaduto.
La contabilità morale
L'attivismo si misura in like, non in azioni. Conti le view di una story, non le firme o le donazioni. Verifichi se sembri "una brava persona", non se hai fatto qualcosa di concreto.
Ho chiesto a venti persone che avevano postato per una causa cosa avessero fatto oltre al post. Diciassette hanno risposto "ho sensibilizzato". Tre hanno ammesso, niente. Nessuna azione reale.
Nemmeno un euro donato, nemmeno un'ora persa. Però hey, hanno usato l'emoji giusta. La sensibilizzazione è diventata l'alibi perfetto: ti fa sentire attivista senza alzarti dal divano.
Il vero problema è che questa logica sta creando una generazione convinta che condividere equivalga a fare. Che mettere una bandierina nella bio sia attivismo. Che repostare un'infografica abbia lo stesso peso di donare, manifestare o votare. Non ce l'ha. Mai avuto, mai avrà.
La performance dell'indignazione
C'è un copione preciso da seguire. Prima posti la story con sfondo nero e testo bianco, possibilmente con un "..." iniziale per enfatizzare il tuo shock. Poi condividi tre o quattro caroselli di "educazione" che hai trovato già pronti. Infine, il post performativo sul feed principale: foto neutra, caption lunghissima in cui dimostri di aver capito tutto della situazione.
Il problema non è l'informarsi o il condividere informazioni. Il problema è quando questo diventa un rituale vuoto, una lista di cose da spuntare per poter tornare tranquilli alla routine. "Ho fatto la mia parte", ti dici. Ma quale parte? Hai premuto un bottone. Hai dato engagement a un algoritmo. Hai fatto esattamente quello che IG vuole che tu faccia, restare attaccato allo schermo.
Dissociazione quotidiana
Chi si commuove per il clima prende l'auto anche per buttare la spazzatura. Chi condivide post sul fast fashion ordina da Shein tre volte a settimana. Chi posta contro lo sfruttamento animale mangia carne ogni giorno. Non è solo ipocrisia: è dissociazione strutturale tra ciò che performiamo online e ciò che facciamo nella vita reale.
Ho osservato una ragazza postare per settimane contro l'inquinamento degli oceani. La stessa che usa bicchieri di plastica monouso al bar perché "il vetro pesa troppo in borsa". Nessun giudizio morale, solo un'osservazione: abbiamo imparato a tenere separate le nostre identità digitali da quelle fisiche. Online ci indigniamo per tutto, offline non ci sbattiamo nemmeno a portare la borsa riutilizzabile al supermercato.
Il tribunale morale
Il giudizio reciproco è la parte più tossica. Se non posti, sei complice. Se posti poco, non ti importa abbastanza. Se posti troppo, sfrutti la tragedia. Ho visto amicizie rompersi per una story mancata.
Abbiamo creato un sistema di sorveglianza morale che non spinge ad agire, serve solo a controllare chi performa meglio la propria bontà. È una competizione nascosta su chi dimostra più empatia, chi ha la caption più profonda, chi usa il filtro giusto per non sembrare troppo allegro mentre il mondo esplode.
Una mia amica mi ha raccontato di essere stata attaccata perché non aveva postato nulla su una determinata crisi. La sua risposta è stata semplice: "Ho donato 200 euro e non ho sentito il bisogno di documentarlo". Silenzio dall'altra parte. Perché quando l'attivismo diventa solo performance, l'azione concreta senza testimoni perde valore. Se nessuno ti vede fare del bene, l'hai fatto davvero?
Le cause come mode
Sudan, Ucraina, Gaza, Congo. Ogni mese un trend nuovo, quello precedente dimenticato. Non perché i conflitti si siano risolti, ma perché non sono più "in". L'algoritmo decide e noi obbediamo.
Ho notato un pattern preciso: una causa diventa virale quando viene amplificata dai grandi account, quando le celebrity la sposano, quando diventa impossibile non vederla. Poi, lentamente, scivola fuori dal feed. Non perché la situazione sia migliorata, ma perché il ciclo delle notizie ha girato pagina.
E noi, docili, giriamo pagina con lui. Ci indigniamo per quello che l'algoritmo ci mette davanti, dimentichiamo quello che l'algoritmo nasconde. Siamo attivisti a intermittenza, accesi e spenti da forze che non controlliamo.
L'empatia esaurita
Trattare ogni tragedia come un contenuto ha un effetto collaterale: anestetizza. Dopo settimane di indignazione performativa non sentiamo più nulla. Ho raggiunto il limite del dolore che riesco a elaborare ogni giorno attraverso uno schermo.
Ogni mattina apro IG e vengo bombardata da notizie devastanti. Morti, guerre, ingiustizie. Tutto presentato con la stessa modalità di un tutorial makeup o di una ricetta. Lo scroll è lo stesso, il gesto è identico. Swipe up per il dramma, swipe up per il prodotto sponsorizzato. Il cervello non distingue più.
Questa saturazione di tragedia non ci rende più sensibili, ci rende immuni. Sviluppiamo una corazza emotiva per sopravvivere al flusso costante di orrore. E quando finalmente succede qualcosa di veramente grave nella nostra vita reale, non abbiamo più risorse emotive per affrontarlo, le abbiamo bruciate tutte scrollando.
L'illusione del contributo
La verità è che postiamo più per noi stessi che per le cause. Per sentirci migliori, per avere la conferma di stare dalla parte giusta. Ma il vero attivismo è scomodo: richiede tempo, soldi, presenza fisica, sacrificio. Richiede di agire quando nessuno ti guarda.
Ho un test semplice per capire se qualcuno è attivista vero o performer: gli chiedo cosa ha fatto nell'ultima settimana per la causa che tanto gli sta a cuore. Se la risposta si limita a "ho condiviso", ho la mia risposta. Se invece parla di volontariato, donazioni, petizioni firmate, presenza a manifestazioni, allora forse stiamo parlando di attivismo reale.
Il mio test personale
Prima di postare, mi chiedo tre cose:
Ho fatto qualcosa di concreto oltre a condividere?
Sarò ancora qui fra un mese, quando il trend sarà morto?
Lo faccio per aiutare o per sistemare la mia immagine?
Da quando lo faccio, i miei post "attivisti" sono crollati del 90%. Non perché mi importi meno, ma perché ho smesso di fingere. Ho smesso di usare le tragedie altrui come decorazione per il mio profilo. Ho iniziato a donare in silenzio, a firmare petizioni senza screenshot, a manifestare senza documentare ogni secondo.
E sai qual è la parte interessante? Nessuno mi ha chiesto perché posti meno. Perché in realtà a nessuno importa davvero cosa fai, importa solo cosa mostri di fare.
L'illusione finale
L'attivismo da vetrina non è solo inutile, è dannoso. Crea l'illusione di un cambiamento che non esiste, distrae da chi lavora davvero, trasforma la sofferenza in contenuto consumabile.
Non importa se hai davvero capito l'argomento, se condividi le posizioni o se hai fatto ricerca autonoma. Conta solo il like, il repost, l'emoji di supporto. È come mettere i fiori (finti) ai funerali, non aiutano nessuno, ma fanno la loro figura nelle foto.
Il mondo non ha bisogno di altre bandiere nelle bio. Ha bisogno di persone che spengano il telefono e facciano qualcosa di reale. Di gente che doni senza postarlo, che manifesti senza taggare, che si impegni quando nessuno sta guardando.
Perché alla fine, l'unica domanda che conta è questa:
quando l'algoritmo passerà oltre, quando la causa non sarà più trendy, sarai ancora lì?
O anche tu sarai già passata al prossimo trend, alla prossima tragedia da consumare, alla prossima occasione per sentirti una brava persona senza alzarti dal divano?